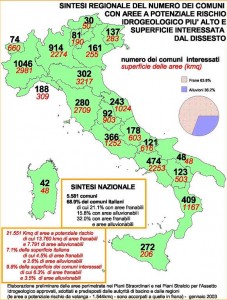 http://bioregionalismo-treia.blogspot.it/2012/11/bioregionalismo-di-superficie-difendere.html
http://bioregionalismo-treia.blogspot.it/2012/11/bioregionalismo-di-superficie-difendere.html
Le parole di Giorgio Nebbia sono come quelle di un padre che vorrebbe salvare i propri figli da una tragedia annunciata come quella che si consuma ogni volta che piove nei territori dove nessuno si preoccupa di quanti perdono il lavoro e spesso anche la propria casa.
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Nebbia
Si potrebbe scrivere una storia dell’Italia elencando le perdite di vite, di ricchezza, di beni, conseguenti le frane e le alluvioni e la siccità, tutte ricorrenti, in tutte le parti d’Italia, con le stesse modalità e cause, tutte rapidamente dimenticate. Come anno zero può essere preso il 1951, l’anno della grande alluvione del Polesine provocata dal dissesto idrogeologico del lungo periodo fascista e di guerra durante il quale si è aggravato il taglio dei boschi ed è venuta meno la manutenzione dei fiumi.
In quell’anno del grande dolore nazionale, ci si rese conto che la ricostruzione dell’Italia avrebbe dovuto dare priorità alle opere di difesa del suolo; molte indagini e inchieste misero in evidenza la fragilità di molti corsi d’acqua, oltre al Po, in cui i detriti dell’erosione si erano depositati nell’alveo e avevano fatto diminuire la capacità ricettiva dei corpi idrici. Inoltre era già stata avviata una graduale occupazione e privatizzazione delle fertili zone golenali, originariamente appartenenti al demanio fluviale proprio perché ne fosse conservata, libera da ostacoli di edifici e strade, la fondamentale capacità di accoglimento delle acque fluviali in espansione nei periodi di intense piogge.
Il “miracolo economico” degli anni cinquanta e sessanta del Novecento è stato reso possibile dalla moltiplicazione di quartieri di abitazione, di fabbriche e di attività di agricoltura intensiva che richiedevano una crescente occupazione del territorio, nelle pianure e nelle valli. Nello stesso tempo la intensa migrazione interna dalle zone più povere e dissestate del Mezzogiorno verso un Nord che prometteva lavoro in fabbrica e paesi e città più vivibili e con migliori servizi, ha lasciato vaste zone del Mezzogiorno e delle isole e delle montagne e colline esposte all’abbandono umano e esposte ad un crescente degrado del territorio e a una serie crescente di frane e alluvioni.
Per una nuova politica del territorio, per avviare serie iniziative di difesa del suolo non servì la frana di un pezzo del monte Toc nel bacino del Vajont, e i relativi duemila morti del 1963. E neanche la grande alluvione di Firenze e Venezia del 1966, un altro momento del grande dolore nazionale; anche allora fu riconosciuta, nel dissesto territoriale la causa prima della tragedia; fu istituita la Commissione De Marchi che riferì al Parlamento che occorrevano investimenti di diecimila miliardi di lire di allora (100 miliardi di euro 2012) in dieci anni per opere di difesa del suolo. Opere che non sono state fatte.
Nei decenni successivi la costruzione di edifici e strade ha continuato ad alterare, anzi in maniera accelerata, profondamente la superficie del suolo creando ostacoli al flusso delle acque; si è innescata una reazione a catena che ha fatto aumentare l’erosione del suolo, i detriti dell’erosione hanno invaso gli alvei dei fiumi e torrenti e, di conseguenza, è diminuita la capacità dei fiumi e torrenti e fossi di ricevere l’acqua, soprattutto a seguito di piogge più intense.
Nello stesso tempo si sta assistendo a modificazioni climatiche planetarie che alterano i cicli delle stagioni e delle piogge. Di conseguenza sempre più spesso, il territorio e la collettività italiani sono (e saranno) esposti a siccità e frane e alluvioni che distruggono edifici, strade, raccolti; sempre più spesso le comunità danneggiate richiedono la dichiarazione di stato di calamità, che significa che lo stato deve provvedere a risarcire i danni provocati da “calamità” considerate “naturali” ma che tali non sono: sono calamità dovute ad errori e imprevidenza umani: per evitarli la politica della “protezione civile” dovrebbe essere sostituita con una cultura della “prevenzione”.
Le frane e le alluvioni derivano in Italia da vari fattori. Dalle piogge, prima di tutto, che si alternano rapide ed intense in certi mesi e scarse in altri; ma come si può organizzare la prevenzione delle calamità se non si sa neanche esattamente quanto piove in una regione in un anno ?
La velocità con cui le piogge scorrono nelle valli, sul fianco delle montagne e colline, e poi nei fiumi a fondovalle, la loro forza di erosione del suolo, dipendono dalla vegetazione: se il suolo è coperto di alberi e macchia spontanea, la “forza” contenuta nelle gocce d’acqua delle piogge si attenua cadendo sulle foglie e l’acqua scorre sul suolo abbastanza dolcemente. Se il suolo è nudo, la forza delle gocce d’acqua lo sgretola in particelle fini che rapidamente sono trascinate a valle e, quando il flusso di acqua è intenso, il ruscellamento si trasforma in un fiume di fango, quello che abbiamo visto tante volte nelle immagini delle alluvioni.
Se poi il flusso delle acque incontra ostacoli, edifici, muraglioni, il fiume di acqua e fango si rigonfia, cambia strada, si infiltra dovunque e spazza via tutto. E di ostacoli le acque sul suolo italiano, in tutte le regioni, ne incontrano tanti: decisioni miopi ed errate e l’abusivismo edilizio, tollerato dalle autorità locali e addirittura incentivato con due devastanti “condoni”, hanno fatto moltiplicare sul fianco delle valli, addirittura nel greto dei fiumi, case, fabbriche, edifici, strade.
Nel 1989 era stata emanata una legge, la “centottantatre”, che stabiliva come rallentare ed evitare i disastri delle frane e delle alluvioni. La difesa del suolo e delle acque deve, indicava giustamente la legge, essere organizzata per bacini idrografici, quelle unità geografiche ed ecologiche che comprendono le valli, gli affluenti, i fiumi principali, dalle sorgenti al mare. Poiché i confini dei bacini idrografici non coincidono con quelli delle regioni e delle province, per ciascun bacino idrografico deve essere istituita una autorità di bacino che deve redigere un “piano” per indicare dove devono essere fatti i rimboschimenti, dove devono essere vietate le costruzioni, deve devono essere fermate le cave o le discariche dei rifiuti, dove devono essere costruiti i depuratori. Al piano di ciascun bacino dovrebbero attenersi — lo voleva la legge, non sono ubbie di ecologisti — le autorità amministrative, i consorzi di bonifica, le comunità montane, gli enti acquedottistici. Anche questa legge è stata abrogata dal testo unico delle leggi sull’ambiente approvato dal governo nel giugno 2006.
Eppure la salvezza del territorio contro le alluvioni e l’aumento delle risorse idriche richiederebbero un grande illuminato programma di opere pubbliche, sull’esempio di quelle intraprese dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, nel 1933, per far uscire l’America dalla crisi con investimenti per la sistemazione delle valli e del corso dei fiumi, creando occupazione e tornando a rendere fertili terre erose e assetate proprio per l’eccessivo sfruttamento del suolo.
Tali opere richiederebbero un piano quinquennale che dovrebbe cominciare con una indagine dello stato del territorio, oggi facilmente eseguibile con mezzi tecnico-scientifici come rilevamenti satellitari e aerei. Tanto per cominciare gran parte di questo lavoro è disponibile, sparso per diversi ministeri e agenzie: in parte è stato fatto (avrebbe dovuto essere fatto) nell’ambito delle autorità di bacino idrografico secondo quanto richiesto a suo tempo dalla legge 183; in parte fu (avrebbe dovuto essere) predisposto dal decreto del 1999 dopo l’alluvione di Sarno. Tale indagine dovrebbe rilevare le vie di scorrimento delle acque dalle valli verso il mare e gli ostacoli attualmente esistenti a tale flusso, rivo per rivo, fosso per fosso, torrente per torrente, fiume per fiume.
Come secondo passo, l’indagine sullo stato del territorio indica (indicherebbe) dove non devono essere fatte nuove opere come costruzioni di edifici e strade e dove sarebbe opportuno localizzare futuri edifici e strade in moda da assicurare il deflusso senza ostacoli delle acque. Le decisioni conseguenti la pianificazione dell’uso del territorio — l’indicazione di dove si può e di dove non si deve intervenire con opere nel territorio — comporta due sgradevolissime conseguenze: la modificazione del valore di molte proprietà private e la necessità di una moralizzazione della pubblica amministrazione alla quale dovrebbe essere iniettato il coraggio di “dire no” alle pressioni di molti proprietari di suoli.
Come terzo passo l’indagine sullo stato del territorio indica (indicherebbe) dove esistono ostacoli al flusso delle acque; tali ostacoli sono costituiti da edifici o opere costruiti, abusivamente o anche “legalmente”, al fianco dei torrenti e fossi, talvolta nelle golene e negli alvei; dalle arginature fatte per aumentare lo spazio occupabile a fini economici e che fanno aumentare la velocità e la forza erosiva delle acque, dai ponti e dalle strade e dalle opere che ostacolano il deflusso delle acque o che si trovano in zone esposte ad erosione, alluvioni e frane.
In parte tali ostacoli devono essere rimossi; sarà una scelta politica trovare delle forme di indennizzo per i costi di spostamento e di demolizione di proprietà private o di opere pubbliche; in qualche caso basta eliminare la cementificazione dei fianchi di colline; in altri si tratta di recuperare e riattivare antiche note pratiche di drenaggio delle acque, abbandonate in seguito allo spopolamento delle colline e montagne; in altri casi si tratta di praticare una pura e semplice “pulizia” di canali e torrenti. Opere di “manutenzione idraulica” esattamente equivalenti alla manutenzione che viene praticata sulle strade, negli edifici, ai macchinari, ma mirate allo scorrimento delle acque.
Come quarto passo, una accurata indagine territoriale è in grado di indicare come è variata, nei decenni, la capacità ricettiva dei torrenti e fiumi; tale variazione è dovuta sia al deposito di prodotti dell’erosione nell’alveo dei fiumi e torrenti, sia all’escavazione di sabbie e ghiaie; nel primo caso le acque piovane tendono ad uscire dagli argini e ad allagare le zone circostanti, e non servono le opere di innalzamento o cementificazione degli argini, ché anzi aggravano la situazione, trasferendo a valle materiali che ostacolano altrove il deflusso delle acque: nel secondo caso i vuoti lasciati dall’escavazione fanno aumentare la velocità e la forza erosiva delle acque in movimento.
Va anche tenuto presente che quanto avviene nel corso di fiumi e torrenti influenza i profili delle coste provocando avanzata o erosione delle spiagge, con conseguente, rispettivamente, interramento dei porti o perdita di zone di valore economico turistico — e quindi ancora una volta costi per la collettività e anche per privati.
La quinta azione — ma dovrebbe andare al primo posto come efficacia — per rallentare e fermare i costi per frane e alluvioni, e per aumentare la disponibilità di acqua di buona qualità, consiste nell’aumento della copertura vegetale del suolo. La presenza di alberi e vegetazione fa sì che la pioggia cada sulle foglie, anziché direttamente sul terreno; le foglie e i rami sono elastici e attenuano la forza di caduta e quindi la forza erosiva delle acque. Inoltre la loro presenza e la presenza di sottobosco rallenta la discesa delle acque e quindi la loro forza erosiva.
Normalmente si ragiona in termini di rimboschimento delle terre esposte ad erosione; il rimboschimento tradizionale richiede pazienza, cultura e conoscenza delle caratteristiche del suolo, oltre che delle specie vegetali, e tempo e manutenzione perché il trasferimento delle piante dai vivai al terreno è opera lunga e delicata; ma l’attenuazione del moto delle acque è svolto anche dalla vegetazione “minore”, dalla macchia e dalla vegetazione spontanea. Purtroppo esiste una anticultura che suggerisce o impone la “pulizia”, che vuol dire distruzione, del verde, dalle campagne alle valli, ai giardini privati e pubblici urbani.
La macchia è spesso estirpata per lasciare spazio per strade o parcheggi o edifici: non ci si rende conto che ogni foglia, anche la più piccola e insignificante, anche quella che cresce negli interstizi delle strade, ha un ruolo positivo non solo come “strumento” per sequestrare dall’atmosfera un po’ dell’anidride carbonica responsabile dell’effetto serra e dei mutamenti climatici, ma anche per contribuire allo scambio di acqua fra il suolo e l’atmosfera — essendo, ancora una volta, l’acqua la fonte vera della vita anche economica.
Alla distruzione del poco verde contribuisce la gestione del territorio agroforestale, l’abbandono dell’agricoltura di collina e montagna, la diffusione di seconde case e attrezzature sportive proprio nelle valli, una parte molto desiderabile del territorio, la mancanza di “amore” per la vegetazione che è la forma prima di “vita”, dalla quale dipendono tutte le altre forme di vita umana ed economica.
La poca cura e protezione del verde spontaneo è la fonte degli incendi (alcuni, molti sono provocati proprio per sgombrare il terreno dal verde che ostacola costruzioni e speculazioni); gli incendi, a loro volta lasciano il terreno esposto a crescente erosione.
C’è una sesta azione di sostegno alle cinque precedenti che avrebbe anche il vantaggio di non costare niente; un’opera di informazione e di “pedagogia” delle acque, di narrazione di come le acque si muovono nelle valli e nelle città, delle interazioni fra il moto delle acque e il suolo e la vegetazione e le opere umane; al di là dell’utilità pratica, appunto per diminuire i costi annui dovuti al risarcimento delle perdite economiche provocate da frane e alluvioni, la “cultura delle acque” avrebbe un valore politico e civile, mostrando come la popolazione di ciascuna valle è unita, nel bene e nel male, dalle acque che scorrono nella valle stessa, mostrando le forme di violenza che opere sconsiderate a monte esercitano sugli abitanti a valle.
Giorgio Nebbia [email protected]

Commenti recenti